Viviamo in un tempo che potremmo definire di estrema incertezza. Il mondo è volatile, complesso, ambiguo: ogni decisione porta con sé una mappa incompleta del futuro. In questo contesto, comunicare non significa più semplicemente “spiegare cosa faremo”, ma partecipare alla costruzione del senso.
In un momento in cui anche chi decide non ha tutte le risposte, l’arte della comunicazione diventa cruciale: come possiamo farlo bene e in modo che il nostro pubblico — clienti, stakeholder, dipendenti— non si senta abbandonato, ma partecipe?
Oscillare tra chiarezza e ambiguità: non è un ossimoro
Molti pensano che la comunicazione efficace debba essere assolutamente chiara. Eppure, fin dagli anni Ottanta, il ricercatore statunitense e professore Eric M. Eisenberg, riconosciuto a livello internazionale come il maggior esperto nella comunicazione efficace della leadership, ha sostenuto che l’ambiguità strategica non è un difetto, ma spesso una risorsa. Nella sua celebre opera Strategic Ambiguities egli argomenta che le organizzazioni — non potendo prevedere tutto — ricorrono a messaggi volutamente vaghi per mantenere flessibilità, includere prospettive divergenti e preservare spazi per l’interpretazione condivisa.
Più recentemente, studi come quello del professore di comunicazione Olaf Hoffjann hanno mostrato che non si tratta di scegliere sempre chiarezza o sempre ambiguità, ma di oscillare consapevolmente tra i due estremi. Le organizzazioni resilienti sanno alternare risposte nette e margini di interpretazione, a seconda del contesto e dell’obiettivo proposto.
Trasparenza calibrata: dire ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo
Uno degli errori più pericolosi in tempi incerti è pretendere di avere certezze quando non le si hanno. La credibilità si costruisce più attraverso l’onestà intellettuale che attraverso l’illusione di infallibilità: significa distinguere ciò che sappiamo da ciò che rimane sospeso.
Questa trasparenza calibrata non è ostentare indecisione, ma spiegare quali sono le variabili in gioco, quali decisioni sono provvisorie e su cosa esistono margini di cambiamento. In questo modo, il pubblico non riceve una risposta “magica”, ma comprende il percorso decisionale e si sente coinvolto.
Linguaggio concreto per resistere al vuoto dell’incertezza
Quando le persone si trovano in un contesto di forte ambiguità, tendono a percepire un vuoto di senso che genera ansia, diffidenza e difficoltà decisionali. È proprio in questi momenti che il linguaggio assume un ruolo fondamentale: non come semplice trasmissione di informazioni, ma come strumento di ancoraggio cognitivo.
Diversi studi in psicologia cognitiva dimostrano che gli esseri umani recepiscano meglio messaggi concreti e specifici. Già negli anni ’70, il linguista Walter Kintsch aveva evidenziato come le frasi contenenti dati tangibili (numeri, tempi, esempi) siano più facili da ricordare e meno suscettibili a distorsioni interpretative. Più di recente, le ricerche di Trope e Liberman (2003) nell’ambito della Construal Level Theory hanno confermato che un linguaggio vicino, concreto e descrittivo riduce la distanza psicologica e rende i messaggi più credibili e persuasivi.
Un esempio pratico: dire “entro tre mesi ridurremo il tempo medio di attesa del 30%” è molto più efficace di un generico “stiamo migliorando il servizio”. Il primo messaggio fornisce una metrica verificabile e un orizzonte temporale chiaro, mentre il secondo lascia spazio a interpretazioni soggettive e, spesso, a scetticismo.
Anche la neuropsicologia fornisce spunti interessanti: studi condotti dalla ricercatrice di Cambridge Stavroula Kousta hanno dimostrato che le parole concrete attivano in misura maggiore aree sensoriali e motorie del cervello, rendendo il messaggio non solo più comprensibile, ma anche più esperienziale. Questo significa che un linguaggio concreto non è soltanto più chiaro, ma anche più “sentito” dalle persone.
In definitiva, nelle situazioni incerte il linguaggio concreto funziona come una bussola: aiuta individui e organizzazioni a non perdersi nell’ambiguità, fornendo coordinate precise e verificabili. Non elimina l’incertezza, ma la rende abitabile, trasformandola da minaccia vaga a sfida affrontabile.
Il canale conta: abbina complessità del messaggio alla ricchezza mediale
Non tutti i messaggi sono adatti a tutti i canali. La teoria della media richness insegna che, quanto più un contenuto è ambiguo, più ha bisogno di un canale “ricco” (video, interazione, feedback immediato) per essere recepito correttamente.
Un cambiamento strategico complesso comunicato via e-mail rischia di essere frainteso; lo stesso messaggio, veicolato via webinar con possibilità di domande, sarà invece compreso con maggiore efficacia. La scelta del mezzo è parte integrante della strategia: i contenuti ambigui appartengono a spazi comunicativi che consentono dialogo e chiarimento.
Comunicare insieme: dal messaggio al senso condiviso
In contesti ambigui, il senso non può essere imposto, ma costruito insieme. Il concetto di sensemaking, introdotto da Karl Weick, professore emerito di Psicologia del comportamento organizzativo presso l’Università del Michigan, mostra come le persone si orientino collettivamente nei momenti di incertezza.
Per questo è fondamentale aprire finestre di dialogo, workshop, sessioni di feedback: clienti, dipendenti e stakeholder diventano co-autori della comprensione del cambiamento. Questo rafforza la legittimazione del messaggio e rende più fluida l’accettazione dei “non detti”.
I rischi dell’ambiguità senza misura: l’ambiguità tossica
L’ambiguità, come abbiamo visto, non è necessariamente un male: può stimolare creatività, apertura e adattabilità. Ma, se non viene gestita e contestualizzata, rischia di trasformarsi in una vera e propria ambiguità tossica.
Il sociologo statunitense Robert Merton già negli anni ’50 descriveva come l’eccesso di informazioni contraddittorie generi role conflict, una condizione in cui le persone non sanno più come comportarsi perché ricevono messaggi incoerenti dalle figure di riferimento. Questo stato produce stress cronico, perdita di fiducia e una riduzione della motivazione individuale.
Più recentemente, studi condotti da Paul J. Hanges e colleghi (2000) hanno evidenziato che l’ambiguità organizzativa non gestita è correlata a un aumento del burnout e a un abbassamento significativo della job satisfaction. In altre parole, se la comunicazione diventa contraddittoria, le persone sperimentano un senso di smarrimento che mina il loro benessere psicologico e la loro capacità di contribuire in modo costruttivo.
Anche dal punto di vista neuroscientifico, un eccesso di ambiguità attiva il sistema limbico, in particolare l’amigdala, responsabile della risposta alla minaccia. Secondo gli studi di Steward Shankman, psicologo e ricercatore statunitense, l’incertezza prolungata mantiene il cervello in uno stato di allerta costante, simile a quello generato da un pericolo reale. Questo spiega perché i messaggi poco chiari, soprattutto se ripetuti nel tempo, possono generare ansia e sfiducia nei confronti delle organizzazioni che li diffondono.
In sintesi, l’ambiguità tossica si manifesta quando manca un equilibrio: il messaggio non lascia spazio alla co-creazione di senso, ma neanche offre coordinate stabili. Il risultato è una comunicazione che erode la fiducia anziché rafforzarla, trasformando l’incertezza in un vuoto difficile da abitare.
Conclusione: creare fiducia nell’incertezza
In un periodo in cui tutto sembra traballare, la vera sfida per chi comunica è saper gestire con equilibrio la tensione tra sicurezza e mistero. La fiducia nasce quando riusciamo a dire ciò che sappiamo e, allo stesso tempo, ammettere con trasparenza ciò che ancora non conosciamo. Si consolida quando il linguaggio che utilizziamo è concreto e dettagliato, capace di offrire punti di ancoraggio cognitivi che riducono il senso di smarrimento. Diventa ancora più solida se scegliamo con attenzione il canale più adatto: i media più interattivi permettono infatti di veicolare contenuti complessi con maggiore efficacia.
Ma la fiducia non si costruisce mai in solitudine. Coinvolgere il pubblico e renderlo parte attiva della comunicazione significa trasformare le persone in veri e propri co-costruttori del senso, attori che contribuiscono a dare significato all’incertezza. Infine, l’ambiguità deve essere usata con misura ed etica: può servire a stimolare la riflessione o a lasciare spazi di interpretazione, ma non deve mai diventare una scusa per nascondere informazioni o eludere responsabilità.
Chi saprà integrare queste logiche non eliminerà l’incertezza, ma sarà in grado di trasformarla in una leva differenziante, in un segno distintivo di credibilità e apertura.
Bibliografia
- https://www.researchgate.net/publication/292522773_Strategic_Ambiguities_Essays_on_Communication_Organization_and_Identity
- https://www.researchgate.net/publication/354508608_Between_strategic_clarity_and_strategic_ambiguity_-_oscillating_strategic_communication
- https://www.researchgate.net/publication/363767551_The_effect_of_ambiguity_in_strategic_environments_an_experiment
- https://www.researchgate.net/publication/227445746_Organizational_Information_Requirements_Media_Richness_and_Structural_Design
- https://www.researchgate.net/publication/257397559_Sensemaking_in_organizations_by_Karl_E_Weick_Thousand_Oaks_CA_Sage_Publications_1995_231_pp
- https://www.researchgate.net/publication/49696315_The_Representation_of_Abstract_Words_Why_Emotion_Matters
- https://www.researchgate.net/publication/292359592_The_representation_of_meaning_in_memory


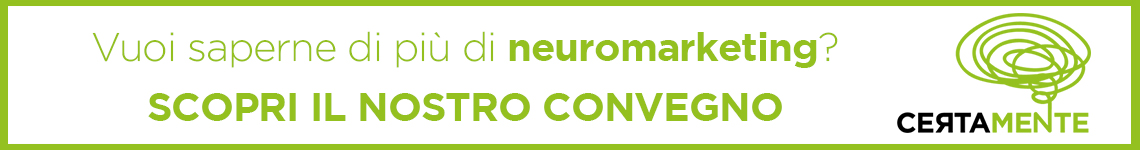





Comments by gabrischettino